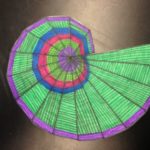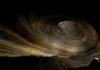Forte di un’ottima organizzazione, il Teatro Grande di Brescia, alle ore 20:00 dell’1 aprile 2017, accoglie un pubblico numeroso (tutto esaurito). Il programma della serata, “La Grande Notte del Jazz”, prevede tre diversi percorsi musicali, coincidenti con i carnet venduti: Ground, Air, Fire. Forse l’Acqua, l’elemento mancante, è rappresentata dal Teatro stesso, nelle cui stanze si ramificano i concerti; oppure è stata espunta per mancanza di spazio, per semplice assenza di affinità con le proposte musicali, o infine è equivalente agli intervalli. Ma lasciamo a queste supposizioni il loro carattere di breve dubbio e procediamo. Saliamo lo scalone d’ingresso, superiamo indenni le maschere e entriamo finalmente in questo bel teatro ottocentesco, timore dei piccoli e vanto dei grandi.
La serata inizia nella Sala Grande con il concerto, comune ai tre carnet, del Pietro Tonolo Trio. La scaletta è azzeccata e introduce in modo discreto e preciso gli approdi espressivi di un linguaggio musicale affinato nel corso di un intero secolo. Sul palco si alternano Onirico, perfetto per addomesticare l’uditorio alle suggestioni estetiche delle ore successive; Basketball, dal ritmo sordo e giocoso come la palla sul parquet e gli scatti e le frenate di una partita; un brano sensuale e planante, che su stessa ammissione dell’autore ha «titolo incerto»; una rivisitazione di un brano di Thelonius Monk da morire dal ridere, tanto è cartoonesca (nonché sottofondo ideale per innocui scherzetti ai propri vicini); e poi il deserto, i cammelli, la chitarra che accompagna sui bassi, l’andamento ondeggiante dei fiati su un tappeto di tamburi ovattati… C’è anche il tempo di presentare uno strumento nuovo, inventato da Monsieur Pietro Tonolo in persona, il flutax, un ibrido tra un flauto e un sax, dal timbro che ricorda il clarinetto, ma più gonfio, più sulfureo – non ho altro mezzo che la sinestesia per descriverlo – e il brano omonimo che lo presenta ha il potere di immergere chi lo ascolta in uno strato profondo della vita interiore. Per quanto ci è stato dato di sentire, lo strumento in questione – l’espressione è maligna, ma rende bene l’idea – sarebbe perfetto in un centro benessere spa. Più in generale, il trio è affiatato (a parte qualche breve defaillance) e sopporta bene la responsabilità del “Grand Opening” (cito da locandina), è elegante, avvincente, con una forte componente di interazione tra i suoi membri e fissa in modo lampante due caratteristiche del jazz moderno: il «tempo fatto di attimi» (P. Conte, Sotto le stelle del jazz) e l’abbigliamento casual (gilet di lana adagiati a camicie fuori dai pantaloni, maniche corte…).
Terminata la prima esibizione i tre percorsi di cui sopra si dividono: c’è chi va nel Ridotto del Teatro Grande per il carnet Ground, chi nella Sala del Palcoscenico Borsoni per il carnet Air. Io proseguirò nella Sala delle Scenografie, perché malgrado i miei tentativi di recuperare un Ground, mi sono dovuto accontentare in extremis di un Fire – e dopo tutto, non me ne posso lamentare. Via dunque fino all’ultimo piano, attraverso i corridoi curvi che abbracciano il salone del palcoscenico. Alcune aperture nei muri scuri e profondi, in corrispondenza delle rampe di scale, lasciano intravvedere le decorazioni del Ridotto, scorci di colori pastello, lampadari e forme geometriche che invogliano ad affacciarsi. Nonostante la foga bresciana di accaparrarsi il posto, nonché il procedere alla cieca, la transumanza verso i pascoli sonori si svolge in modo semplice e ordinato, grazie anche alla disponibilità dei butteri-maschere.
All’ultimo piano ecco dunque un gruppo finlandese – tali Elifantree – che nonostante un inizio rasente la pazzia e l’incomprensibilità sconclusionata (la fine del primo pezzo e gli applausi sono stati divisi da un silenzio incerto), mano a mano che procede acquisisce sicurezza e potenza e riesce a esprimere compiutamente la propria poetica. Una voce femminile intensa, gutturale, lirica e piena di grida, con repentini cambi tra strozzature, aperture improvvise e modi scanzonati, conclude un’ebollizione di pianoforti, sintetizzatori, percussioni che sono sberle profonde, sassofoni che non sono più sassofoni, carichi di effetti, delay, sequenze e progressioni… È l’elettronica, baby! Nulla di radicalmente nuovo, ma che slancio, che emozione! Tre brani, di cui non so affatto i titoli, mi hanno colpito particolarmente, e credo che andrò a spulciare la discografia del gruppo nella speranza di ritrovare qualcosa di simile all’impressione che mi ha lasciato. Nonostante il mio pregiudizio per ciò che chiamo la depressione nordica (in effetti, durante la canzone più cupa mi viene da ridere), la rabbia soffusa nella voce e l’incalzare di sax e batteria (sono un trio, ma saturano l’aria) danno vita a un moto lirico elevato, un invito per il corpo al movimento.
Intervallo. Cominciano i primi segni di cedimento, sia da parte mia che di altri. Nella Sala Grande RJ Miller prova a stuzzicarmi con una batteria e suoni lunghi, ma preferisco il silenzio musicale, il brusìo e un calice di vino (pagato a caro prezzo). Ci annunciano che in via straordinaria si può accedere al Caffè degli Artisti, non si può perdere l’occasione: e via nei corridoi. Malgrado si possa pensare che il locale, in forza del suo nome, sia un fiore all’occhiello dell’edificio, bisogna ricredersi perché, proprio in forza del suo nome, è un retrobottega spoglio, che non manca comunque di offrire una nota di colore, unita all’entusiasmo di varcare zone solitamente proibite. Nel frattempo penso ai fasci di luce, le belle luci monocrome che piovevano sul primo trio, accompagnandone i passi di brano in brano, verde, rosso, blu. Sarei già sazio, e siamo solo a metà…
Quella stessa atmosfera luminosa la ritrovo nel Ridotto a cui mi conduce l’itinerario: c’è un pianoforte verso cui si dirige una ragazza giovane, modesta, che prende subito a lavorare sui tasti, mentre gli ultimi arrivati stanno ancora cercando posto a sedere. Lentamente, lentamente il volume cresce, introduce nuove sequenze, e la grande sala e il suo soffitto affrescato di nuvole sembrano comprimersi e dilatarsi più la musica si concentra e si distende. I putti laterali si rimirano agli specchi, dalle balconate compare un pompiere (a proposito, si veda il divertente racconto di C. E. Gadda, Teatro)… e crescono i segnali di impazienza di cui è prodiga Brescia. Due tacchi tentano la fuga, trovano la porta sbarrata, si sentono in trappola. Il pubblico scalpita, inizia a chiacchierare. La testa di un signore due file più avanti alla mia ciondola pericolosamente all’indietro. Scosso dagli applausi – speranzosi in una fine – applaude meccanicamente, ma si riaccascia poi su se stesso come un sacchetto triste, il collo incassato, il capo leggermente inclinato a sinistra. La pianista propone un materiale artistico libero, dissonante, parossismo di Ravel, arricchito di batacchi sulle corde bloccate da un quaderno e qualche campana tibetana, ma pur crescendo e sviluppandosi sembra sempre rimanere lontano. Credo che anche lei senta l’insofferenza diffusa, e non manca di vendicarsi con suoni acuti improvvisi e dolosamente sforzati. Finisce sbrigativamente. L’aggettivo per me finale per descriverla è: diafana. Scappiamo tutti verso il secondo intervallo. RJ Miller, non mi avrai neanche questa volta.
L’ultima esibizione a cui assisto, oltre che per curiosità, per… avarizia (per sfruttare al massimo tutti i trenta euro del biglietto) mi trova letteralmente sfinito e affamato: sono le 2:00 di notte. In compenso, il luogo in cui si svolge è meraviglioso: la Sala Palcoscenico Borsoni, vale a dire il retro della ribalta, diviso da un telo nero semitrasparente dal resto della Sala Grande, di cui si vedono le cinque file di luci dei loggiati come di una grande nave. Infine sbucano anche loro: le scarpe da ginnastica e gli stivaletti pitonati a punta. Il Teatro Grande, tempio della musica classica, è definitivamente conquistato e lo spettacolo offre un curioso contrasto. Suona il Fabrizio Puglisi Trio, molto piacevole, anche divertente, con assoli di contrabbasso «buonissimi» (come direbbe un mio amico argentino), in un’atmosfera di coni di luce che dall’alto circoscrivono piramidi di fumo (forse è polvere, ma sono comunque degne degli standard proposti e dell’ambientazione). Unica pecca, un brusio di fondo dell’impianto di amplificazione.
Finito il tour de force, sono così pieno di suoni, così stanco dopo una giornata di lavoro e di ascolto, che non penso affatto all’interessante rassegna a cui ho partecipato, in forma di avventura. Ho camminato per il teatro come in una casa accogliente, ma voglio solo andare a dormire. Ciò non mi dispensa però da un’ultima considerazione finale. La Grande Notte del Jazz ha riconfermato due capisaldi bresciani nella gestione degli eventi: le grandi abbuffate culturali e l’impazienza da proverbio; due forze che scalpitano e si danno battaglia, compensandosi segretamente nella ridente vita cittadina.
Giacomo Cattalini