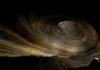L’orgasmo di Rādhā è sì l’estasi dell’anima posseduta da dio,
ma quell’anima palpita nella carne.[1]
Un peccato mortale che l’uomo compie, da quando l’amore ha trovato il modo d’insinuarsi fra le sue ossessioni, è quello di agire con lo slancio del corpo credendo di essere comandato (e/o condannato?) dal cuore. Diventa così indispensabile e comodo il convincersi d’essere caduto innamorato, prescelto, dove invece a dominare è l’attitudine invincibile alla ricerca del piacere, del tragico amplesso che doni, infine, la soddisfazione definitiva, come un esorcismo che liberi anima e corpo da un demone incomprensibile (un essere a metà fra l’umano e il divino, che si lascia avvicinare e mai toccare, un mistero appena sfiorato e subito dissolto, disperso dal vento). Ad aggravare l’eterno frainteso è la naturale (e quasi istintiva, si potrebbe dire) caccia alla preda clamorosa, l’acme dell’eros mostruoso che ci sorprende tutti affannarci verso un solo desiderio, incarnato da quell’unica preda dorata. La totale perversione di questo anelito, con assoluta e giustificata sfortuna del maschio, risiede nelle placide correnti della donna che si ritrae nell’incompreso concedendosi: cosa accadrebbe, invero, nell’istante in cui la più ambita fra le dolci pesche concedesse a tutti di suggerne uno spicchio? Se d’improvviso a chiunque, senza distinzione di rango, possibilità economiche, giudizio estetico, fosse consentito sorbire il fresco nettare? Ecco giungere, con inusitata violenza, la depravazione del concetto civile, addirittura religioso, di amore (la razza, è pur vero, non s’estinguerà!), sgretolato dall’urgenza del dominio sessuale sopra il resto della specie; troveremo l’uomo sputare inebetito contro quel delicato fiore, spergiurare d’abbandonarlo alla violenza delle intemperie, salvo poi tornare ogni giorno sui suoi passi per prendersi cura di quell’esile creatura ed abbandonarsi al suo profumo e al tenero solletichìo dei suoi petali. E la controparte femminile, abbandonata alla soglia del focolare domestico, i Mani come unica compagnia? A quella, non resterebbe che la disperazione dell’ingiuria, lo spargimento dozzinale del seme fedifrago che ottunde la ribellione; tutto ciò impastato alle lacrime che mai potrebbero placare il disastro del fallimento. Il pensiero corre ai pargoli, ancora in fasce, che nemmeno ricorderanno i visi incorniciati da barbe spesse e rughe premature: le colpe dei padri ricadano sui figli, il loro sangue sia per la prole veleno. Ed ultimi, soltanto per il numero di primavere sulle spalle, gli anziani turbati, che assistono impotenti (in tutti i sensi) al ratto violento del buon nome di famiglia, forgiato con la fatica e l’avarizia, gettato infine nella fanghiglia di un canale di scolo da quei figli creduti savi e consumati invece da una passione mediocre, ordinaria. Piace pensare che se potessero, correrebbero loro stessi ad inzaccherare le suole del loro rispetto, come i porci accorrono verso il trogolo al richiamo del porcaio.
Pope Vujadin, l’oscuro
Pope Vujadin è il principio: figlio, nipote e nipote bis di una dinastia di pope, era però diverso da suoi antenati. Covava in lui una sorta di tenebra, nonostante fosse un ragazzo istruito, bello, innamorato e padre. L’esplosione dell’oscurità che lo divorò nei pochi anni seguenti avvenne alla morte della moglie, per parto: l’unica donna che per lui fosse mai esistita. Da quel momento, la solitudine intaccò ogni possibile rapporto umano. E liberò, dalla gabbia sociale in cui il disgraziato Vujadin l’aveva rinchiusa, la sua anima sessuale di voyeur. Sudato, allucinato, il pope vaga per strade secondarie evitando ogni contatto che non sia necessario. Dalla finestra della spoglia canonica, nella latebra che l’ombra degli infissi gli concede, complice, egli spia le donne del paese, donne e mogli anche, mentre avvampano chine al fiume intente a lavare i panni sporchi. Quest’immagine incrina le residue difese di colui che, fino ad un mese prima, era il pastore dei paesani. Il desiderio gli scava occhiaie profonde, cuce le sue labbra, avvelena le sue notti agitate. E durante una passeggiata, con la banale scusa del prendere una sorsata d’aria fresca, ogni possibile supposizione di salvezza crolla nel suo spirito con il fragore di un’eruzione: Vujadin scorge un gruppo di giovani, un ingegnere e due ufficiali austriaci in compagnia di due donne; gli ufficiali con la divisa sbottonata per il gran caldo, le donzelle in abiti leggeri d’un bianco accecante, forse di lino. Non visto, egli anticipa ogni possibile mossa: “Come un’immagine di sogno, quella scena lo confondeva e lo eccitava…”[2]. La sua perversione, ormai inoccultabile, gli dispiega l’osceno indicibile a cui i presenti si abbandoneranno davanti ai suoi occhi. E poco dopo, come se lui avesse il potere di un dio, di guidare gli eventi nel nodo temporale stabilito, i due ufficiali in compagnia della più giovane delle donne abbandonano gli altri due per una passeggiata. Rimasti soli, l’ingegnere e l’altra donna si premurano di usare un lembo del lenzuolo steso sull’erba per celare le pudenda: ciò che sperava e temeva Vujadin si abbatte su di lui senza pietà. Nemmeno la fuga dalla vista dell’atto lo può salvare; la corsa a perdifiato verso la canonica è ottenebrata dalla fantasia sfrenata che proseguirà e colorirà senza pausa il coito al quale egli ha sottratto gli occhi, ma soltanto quelli: egli sta vivendo quel rapporto che non gli appartiene; è il ratto violento della passione altrui. Questo rappresenta per il pope il punto di non ritorno: da questo momento, la follia generata dalla volontà di repressione sessuale lo ghermirà impietosamente, gettandolo in un ospedale mentale in ci morirà dieci anni dopo, “… in una stanzetta semibuia, senza aver più coscienza né di sé né del mondo …”[3]: sembra quasi che Dio abbia punito il suo pastore, per aver ceduto all’oscurità incomprensibile che si annida in ognuno di noi.
È dal cedimento di pope Vujadin, un singolo essere umano gettato nel tritacarne della Storia sessuale dell’Uomo, che inizia la lezione di Ivo Andrić: che si espanderà ad un intero villaggio, distrutto (sessualmente e civilmente parlando) dalla malia del Diavolo. Il singolare come lezione per l’universale: Achille che viola il corpo senza vita dell’amata Pentesilea dopo averla combattuta per il predominio guerriero e sessuale, la follia erotica delle baccanti che sbranano Orfeo.
Anika è la Donna, Anika è il Diavolo
Andrić dà alle stampe Anikina Vremena[4] nel 1931, ammantando la storia di una seduttrice (suo malgrado, almeno inizialmente) con l’aura della leggenda, una malinconica sonata balcanica che ci coglie nel bel mezzo di un’accaldata serata estiva di tra gli ulivi, un improvviso refolo di vento a rinfrescare il corpo sudato, ma che sappiamo non destinato a durare. Tendiamo l’orecchio, invasati e trascinati, ma il cuore che batte forte ci avverte che già conosciamo il triste finale della melodia. Nondimeno, l’occhio scorre la pagina avido, le parole rotolano a valle lente eppure indomabili. La genesi di Anika, la sua nascita e gli anni dell’infanzia sono ormai circondati dall’oblio, da quella dimenticanza malsana che spinge l’essere umano ad eliminare col silenzio quegli attimi incomprensibili ed etichettati quindi come Male. Nessuno, al paese, è disposto a raccontare le origini del Diavolo: a giocare col fuoco, prima o poi ci si scotta. “Nella cittadina, dove uomini e donne si somigliano come una pecora somiglia alle altre, accade a volte che il caso porti un bambino, come il vento un seme, destinato a tralignare, a uscir di riga e a provocare sventure e turbamenti, finché non gli si rompano le gambe e non torni così l’ordine antico”[5]. Ecco, in breve, come nasce Anika, come ha origine il suo inglorioso mito. Nessuno bada a lei fino all’età in cui fiorisce la donna: il cucciolo del demonio vive riparato fino a che non è in grado di abbandonarsi al male in autonomia. È all’entrata della chiesa, dopo un inverno immotivatamente lungo (sinistro presagio?), che ella cattura tutti gli sguardi e lancia, ancora incosciente, il suo incantesimo su tutta la cittadina. La bimba gracile che aveva vissuto nel chiuso delle sue stanze lascia il posto ad una figura slanciata, dalla pelle diafana che incornicia in volto dei grandi occhi viola, ed una bocca piccola naturalmente rossata (il diavolo è l’animale più attraente e imprendibile anche per il buon cacciatore, recita un detto serbo). “Da quando era stata fondata quella città, da quando la gente nasceva e si sposava, non c’era mai stato un corpo simile, mai una simile andatura e un simile sguardo. Tutto ciò non era nato e non s’era sviluppato in rapporto con quanto lo circondava. Era capitato lì da chissà dove”[6]. L’abbiamo detto, il Diavolo non ha dimora, il Diavolo è ovunque. Più di qualsiasi descrizione fisica, è la presa di coscienza (purtroppo inutile: non esiste elisir che possa curare l’avvelenamento prodotto da Anika) dell’insolito, dell’imprevisto contro cui non si hanno possibilità, a stordire gli abitanti. Andrić gioca abilmente celando l’esplicito dai rapporti ambigui che si aggrovigliano nel chiuso degli appartamenti della serpe tentatrice, gettando però sulla piazza del racconto i panni sporchi raccolti nelle stanze a giorno fatto. Ciò che rende Anika l’improvvisa e imprevista Afrodite fra le strette viuzze del villaggio è il suo flessuoso sistema di comando: quando agli occhi degli ignari cittadini appare vago il suo disegno, tutti sono ormai perduti fra i flutti di quell’oceano erotico innominabile e attraente. Divide et impera, nella sua declinazione più intransigente; e presto la notte si potranno sorprendere poveri reietti piangere in gruppo il comune rifiuto, ululando sotto le finestre della dea amata il loro struggimento: e purtroppo inutilmente. Se quel dì le bizze dei seni di Anika dovessero celare loro l’accesso al boudoir, non resterebbe loro che lasciarsi scoppiare il cuore di desiderio. Duplice è la dittatura sessuale del diavolo dal profumo di rosa: dove il branco di lupi assetati di sangue vizioso assedia la tana da cui si spande il dolce profumo di nettare, nelle caverne da questi abbandonate le compagne perdono il pelo nel buio dell’oblio quotidiano. Questa è appunto la chiave di volta: Anika, pur rappresentando lo straordinario, straripa elastica nella tentazione quotidiana di tutti gli uomini, dettando legge con i suoi tempi, i suoi modi. Finirà per stregare persino il figlio di un Pope andando a conquistarsi, con silenziosa intransigenza, il primato sul potere temporale. Non esisterà, su una distesa di chilometri, alcun animo maschile in grado di sottrarsi al suo incantesimo (eccezion fatta, come detto, per quei vegliardi cui l’impotenza dona naturale antidoto), al suo invito ad abbandonare la memoria quotidiana fra i suoi guanciali, fra carezze, coiti e stordite urla di piacere belluino. L’equazione è perfettamente bilanciata: Anika, il male incarnato nello spirito della tentazione carnale, distilla lo spirito di belva di ogni uomo, rivelando alla luce della luna il devastante fallimento del canone civile. Non esistono convenzioni in grado di incatenare il branco selvaggio, in cui ognuno attende con sguardo miserando il proprio turno, elemosinando un’ombra fuggitiva di piacere. È Andrić stesso a calcolare il racconto al millimetro, poggiando l’intera struttura dell’esigenza sessuale sul bisogno dell’amplesso intarsiato accanto alla materia fisica bramata, ma celando tutto questo affannoso e sudato gioco erotico alla luce della luna. Sulla faccia lercia della moneta della vita, Anika mai si lascia andare ad un linguaggio scurrile e raramente si sente in obbligo di schiacciare col calcagno una “vedova” (così si definiranno le mogli ripudiate dai mariti ammaliati) che invade il suo lussurioso dominio; il rovescio della medaglia è quello su cui Andrić incide a fuoco sacro la sua morale: sono le rispettabili eminenze in comando a mostrare il loro volto, quando la variabile sessuale arriva a turbare l’equilibrio che toccherebbe loro preservare. Da qui provengono le maledizioni, gli spergiuri, gli insulti più bassi e lascivi. Dove Anika fallisce nel tentativo di carpire i loro corpi, riesce nel tentativo di trascinare le loro anime nel regno del torto. Dove spadroneggia, fra le nebbie degli incensi, proprio la Donna, il Diavolo.
Mihajlo è la vittima, Mihajlo è il carnefice
Accanto alla carne tentatrice di Anika, nel piccolo villaggio espia il tormento della propria esistenza Mihajlo, un giovane letteralmente schiantato dalle proprie colpe. Un’anima, la sua, che già aveva sperimentato le gioie e i dolori che il sesso può regalare: anni prima, lontano, aveva consumato una relazione umida e banale con la moglie d’un oste, poi ucciso con la sua stolida complicità. Tutto gli era rovinato addosso d’improvviso, trovandolo impreparato, indifeso; il suo cuore era aperto soltanto alle delizie dell’amore appena scoperte, ancora acerbe, non alle sue conseguenze. L’omicidio gli aveva spalancato l’abisso della responsabilità di sotto ai piedi senza preavviso alcuno: una lezione che certo non avrebbe scordato. Da otto anni le notti di Mihajlo si addensavano attorno al nucleo della colpa, guastando per sempre la gioia dell’aver finalmente conosciuto il sesso (e viene rispettato il canone tradizionale, che prevede che l’avviamento di un giovane alle gioie della carne venga officiato da una fedifraga, e qui Andrić decide di attenersi al canovaccio). Senza esserne pienamente consapevole, la sua fuga diventa un percorso di redenzione: agire rettamente per fare ammenda, aspettando di incontrare finalmente la donna che lo possa liberare dalla maledizione in cui la moglie dell’oste l’ha imprigionato. È questo secondo passo ad addolorare Mihajlo oltre ogni misura: nel volto di tutte, egli scorge il volto della vipera assassina, che lo inchioda nel coito più colpevole che potesse immaginare. Ma tutto collassa nella nebbia del mattino in cui vede Anika; l’incedere naturale, quasi irresponsabile della ragazza, un’apparizione diafana, forse onirica, lo risveglia d’improvviso dal suo colpevole torpore. La cicatrice provocata dal coito omicida, una ferita che sembrava destinata a chiudersi lentamente, riprende in quel preciso istante a pulsare dolorosamente. Egli non poteva sapere allora in quali voragini dello spirito l’avrebbe condotto quell’apparizione. Soltanto un anno dopo, un intero anno in cui egli si strugge senza risolversi a fare un passo decisivo per conquistare la ragazza, la cruda visione ciclica della storia gli si ripresenterà, e la notte senza luna del torto l’avvolgerà abbandonandolo alla più bieca disperazione: più guarda Anika negli occhi –“Gli occhi di Anika, di solito scuri, erano adesso illuminati come dal di dentro, chiari e opachi a un tempo; si riempirono nello stesso istante di sangue e di lacrime, avvampando del loro colore e del loro scintillio, mentre lo sguardo diventava tagliente, netto e duro.”[7] – più realizza che non c’era modo di fuggire, di espiare. Tutto l’orrore covato per un paio di notti d’amore esige in quell’esatto istante il pagamento. E così si ritrova ad arretrare sommessamente passo dopo passo, trovandosi con le spalle al muro, immaginandosi forse con le braccia penzoloni davanti al plotone d’esecuzione della Storia, gli occhi chiusi in attesa della raffica che lo possa infine liberare dai suoi fantasmi. Non c’è altro modo, morire da vittima pregando di non passare per martire. Ecco che il lento ritrarsi verso le quinte del racconto assume un preciso significato, la brama amorosa e ferinamente sessuale repressa dal delitto fino allo scioglimento nel quale, in una sorta di tutto per tutto immaturo e pretenzioso, egli si mostra pronto ad interpretare il ruolo che, in fondo, crede gli sia sempre stato richiesto: quello del carnefice. “È giunto il momento di estrarre il coltello dalla ferita. Non serve a nulla ingannare se stessi.”[8]
La realtà del racconto appare così straniante, che presto si finisce per non prestare attenzione al destino dei protagonisti ed anzi è questo ciò che meno importa. Pur restando Anika il centro gravitazionale attorno a cui orbita il lieve senso di attrazione ed orrore che attanaglia il lettore, il colpo di grazia è sferrato dalla coralità. Siamo spalle al muro, siamo tutti uguali davanti alla Donna: qualunque sia il rito di iniziazione, qualunque sia la vergogna che ci impedisce il pellegrinaggio al suo cortile con la luce del giorno, alla speranza che ci concede l’amica notte tutti siamo destinati a prostrarci per elevarLe la nostra preghiera. Il rifiuto di Anika ad essere considerata un mero strumento, un corpo che risponda ai bisogni prettamente sessuali della sfera maschile, è peculiare: ella è un essere umano, impegnata nel ricevere così come nel dare. E dunque doppiamente pericolosa, in quanto simbolo. Lei conosce i suoi amanti, uno per uno, e dove un giorno si abbandona a loro senza indugiare lo sguardo sul loro viso, con fare quasi neghittoso, il dì seguente se li conta sulle dita di una mano, come fossero il suo gregge: lupi mutati realmente in agnelli. Vien quasi da sorridere, pensando a quella Circe che aveva mutato in porci gli uomini sotto il comando di Odisseo: eppure le due maghe (o dee?) avranno destino ben diverso. Ma i soggiogati da Anika, possono giurare di aver letto, anche soltanto una volta, nella sua anima? O le graziose pieghe del suo bacino, bianche come il latte, non sono che la corteccia? Per loro ella sarà sempre un’illusione: essi non possiedono gli strumenti, della mente e del cuore, per penetrare il suo segreto e liberarsi così dal suo incantesimo. Essi sono carne corruttibile, ma non per questo meno degni di stare al mondo: se vogliamo prendere appunti su questa lezione, la somma del racconto è forse che male e bene hanno ottenuto lo stesso diritto a stare al mondo.
E nemmeno una volta ristabilito l’ordine costituito tornerà il sereno: con buona pace degli insicuri, che fiutano ovunque odor di trappole e lezzo di pericoli, tutti sanno che il seme diabolico è destinato a germogliare nuovamente, a devastare il rigoglioso campo del quieto vivere comune. È soltanto il copione del Diavolo, della Donna: mettere a nudo (in tutti i sensi) le debolezze di cui l’uomo non sarà mai in grado di liberarsi.
In ogni donna c’è un diavolo che bisogna ammazzare
o con il lavoro o con i parti o con tutte e due le cose.[9]
Mattia Orizio
[1] Dal commento di Marguerite Yourcenar allo Gītagovinda, Jayadeva, Adelphi, 2009, p. 185.
[2] I tempi di Anika, Ivo Andrić, Adelphi, 1990, p. 17.
[3] Ibid., p. 27.
[4] Il testo, come si evince dalle note precedenti, è edito in Italia per i tipi di Adelphi con il titolo I tempi di Anika, 1990, trad. Lionello Costantini.
[5] I tempi di Anika, Ivo Andrić, Adelphi, 1990, p. 31.
[6] Ibid., p. 86.
[7] Ibid., p.56.
[8] Ibid., p. 112.
[9] Ibid., p. 109.