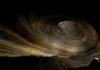Il clima non è certo favorevole per una forte invettiva sul film che sta per diventare – o forse è già diventato – l’ulteriore simbolo di vanità di una classe culturale autoreferenziale che, avendo perso ogni capacità critica, promuove ciò che a priori soddisfa personali prese di posizione, visioni unilaterali della realtà, concezioni coltivate in cenacoli ristretti, dove si respira aria viziata (fritta, nello specifico). Ma non è questo d’ostacolo per una sana polemica spinta, nell’ambito di una rivista che gode della più ampia forma d’autonomia, intellettiva soprattutto. E non sarà qualche like o follower in meno a scoraggiarci. Quindi, si va avanti!
Degli aspetti cinematografici di Chiamami col tuo nome è presto detto.
La sceneggiatura (quanta parte ha avuto J. Ivory?) è una linea piatta senza ritmo, né snodi, e gli autori sembrano compiaciuti all’idea che meno informazioni si offrono allo spettatore meglio è, ad eccezione di dettagli evocativi di un’intellettualità vuota, senza scopo (qual è l’etimo di albicocca?).
La regia si rivela sonnolenta quanto la scrittura; non diviene estro che riscrive con le immagini la trama, ma pedissequo animale da compagnia che fa solo quello che chiede il padrone, cioè, nel caso di specie, Luca Guadagnino e la sua personalissima e intima rappresentazione di un adolescente che s’innamora di un ventiquattrenne in uno specifico spazio-tempo (da qualche parte, in nord Italia, nel 1983).
Infatti, la sua regia è mera composizione ritrattistica (le scene – i singoli affreschi – si succedono placidamente), le inquadrature sono prevedibili e banali, oltre che statiche, e i dialoghi monocordi nelle visuali come nei testi: da questo punto di vista c’è una perfetta sintonia di ogni elemento registico: pacifismo ad oltranza.
Il montaggio è pressoché inesistente: anche qui, una semplice successione di scene e nessuna creatività, ma non c’è da recriminare: se la trama non ha accenti come può averli il montaggio? Si fa quel che si può.
In realtà, questo infelice esito cinematografico è il risultato di un fecondo contesto culturale italiano che, in vista di una tanto sospirata pacificazione, ha eliminato dal proprio orizzonte di conoscenza e meditazione la natura umana e, di conseguenza, una delle sue essenziali componenti: il conflitto. E quando si parla di conflitto non si evocano guerre, violenze e atrocità (pure espressione di un conflitto), ma quella condizione che ci impone di optare nella quotidianità tra comportamenti, atteggiamenti, reazioni, emozioni, sentimenti, tutti astrattamente e biologicamente possibili e praticabili. In estrema sintesi, alla base di ogni atto (fisico, psichico, intellettivo) c’è sempre un conflitto tra: il bene e il male, l’essere e il dover essere, l’osservanza di una norma (qualunque) e la sua trasgressione, la responsabilità o il suo contrario, la riflessione o l’impulsività. Aggiungiamo che le norme, l’etica, la morale, i comportamenti, cambiano nei secoli e nei decenni, e con essi le valutazioni soggettive, e risulterà chiara l’immanenza del conflitto nella nostra misera abitudinarietà. E se mai scoprissimo, ad un certo momento dell’esistenza (individuale o sociale), che il conflitto è sparito, le nubi diradate, splendendo sopra le nostre teste un sole luminoso in un cielo azzurro, dovremmo concludere – a parte l’ipotesi ultima della morte – di essere entrati, dopo un lungo percorso accidentato (il conflitto, appunto), in una fase transitoria di beatitudine, in attesa di nuovi ed altri conflitti.
Ecco!, in Chiamami col tuo nome il conflitto non esiste: non c’è travaglio personale, non c’è contrapposizione famigliare, non c’è contrasto con l’ambiente, non c’è remora etica o giuridica (eppure c’è di mezzo un minorenne); tutto fila liscio come l’olio in un mare di comprensione/accoglienza. Il centro abitato, di Crema o di chissà dove, pare essere indifferente a quanto gli accade intorno (le comparse-passanti non interagiscono con ciò che si scatena nel film), perché assume rilievo esclusivo il soggettivismo più estremo, avulso da ogni possibile contesto. Residua, sotto forma di minimo intoppo narrativo, il più incolore equivoco d’intenti tra i protagonisti (non comprendono subito che c’è attrazione reciproca, ma pronta interviene la madre del minorenne a metterlo sull’avviso): tranquilli! la vicenda si risolve poco dopo, felicemente, nel peccato carnale consumato. Le lacrime finali dell’adolescente, d’infelicità o tristezza, sono estranee ad ogni reale travaglio e si presentano passeggere, effimere, perché non affondano nel caos delle possibilità. L’adolescenza di per sé, fuori dal magma inafferrabile delle pulsioni, è fatto di nessun rilievo. Quelle lacrime, quindi, non emozionano.
Niente a che vedere con la formazione, questa sì tragicamente conflittuale, del protagonista di Moonlight, del regista Barry Jenkins (recensito su questa rivista – https://tinyurl.com/isorci-7), e tantomeno con film molto più datati che hanno messo in scena analoghi desideri sessuali, e i connessi conflitti sociali, individuali e famigliari, dentro mirabili forme artistiche (My beautiful laundrette di S. Frears, 1985; Maurice di J. Ivory, 1987; My own private Idaho di G. Van Sant, 1991; I segreti di Brokeback Mountain di Ang Lee, 2005).
Questi film in un remoto passato ci hanno educato molto bene, culturalmente e civilmente, a siffatte tematiche, invitandoci a sguardi ampi, controversi, dubitativi, e non ci sarebbe stato bisogno di questa fiera del soggettivismo spudorato se avessimo saputo tramandare a chi quei tempi non ha vissuto l’esigenza di un pensiero sempre attento, affilato, rigoroso, tenace, non privo di slanci fortemente emotivi. Si è perso molto tempo, purtroppo.
Michele Mocciola