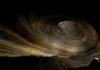La Casa di Carta – parte terza è uscita, e io come voi me la sono goduta appieno. Invero, su questo seguito della serie Netflix dal successo planetario aleggiava il sospetto di una mera operazione fanservice, il timore di assistere a una coda stiracchiata (potenzialmente disastrosa) della trama precedente (un po’ com’è successo, a mio avviso, con la seconda stagione del teen drama Tredici).
D’altronde, con la conclusione dell’assurda, serrata ‘non-rapina’ alla Zecca di Stato, non s’era forse detta la parola Fine? Non s’era perfettamente esaurito nelle sue due stagioni narrativamente unitarie, questo rocambolesco simil-remake di Inside Man? Non aveva forse compiuto l’intera sua parabola, questo meccanismo a orologeria d’intrattenimento macina-tutto, densissimo e insieme centrifugo, capace di coniugare Dalì e V per Vendetta, di miscelare l’esagerazione cinematografica all’americana, sulle orme di Oliver Stone e Tarantino, e l’esuberanza tipica spagnola, sulla scia di Almodovar e Alex de la Iglesia? (Per inciso, questo regista è il vero nume tutelare della Casa di Carta sul piano stilistico, secondo me).
La serie era stata persino in grado di intercettare, nella leggerezza trascinante del divertimento puro (pure un po’ caciarone), lo spirito del nostro tempo, con i suoi nodi problematici, mettendo sul piatto nientemeno che la distanza se non il conflitto latente, ma sempre più pressante, nelle società cosiddette democratiche, tra le autorità costituite, i poteri vigenti, da una parte, e le popolazioni scontente, le masse disorientate dall’altra. In questa finzione, per fortuna, non ci sono i partiti populisti a carpire e deformare bisogni e desideri legittimi del popolo, ma quest’ultimo trova un punto di riferimento nei simpatici fuorilegge protagonisti, spontanei portatori di un’esigenza paradossale di giustizia sociale (il popolo sa sulla propria pelle che la ricchezza mondiale è nelle mani del noto 1%) e di quei valori comunitari che le istituzioni legali dimenticano o calpestano: l’affetto, la solidarietà, il senso della famiglia – fuori da ogni definizione troppo stretta, dalla strumentalizzazione politica, dalla contrapposizione artificiosa fra tradizionale e non. Infatti, se in una puntata i criminali-eroi intonano Bella Ciao, in un’altra recitano il Padre Nostro, senza il minimo sentore di una contraddizione. Insomma, la Casa di Carta avrebbe addirittura messo in scena una carnevalesca, magnifica ribellione dell’Europa storica, popolare, culturale, spirituale, dalle molte anime, contro l’Europa arcigna e raggrinzita del presente, del Potere (poliziesco, statale, sovranazionale, capitalistico)… Che altro si poteva aggiungere, di grazia?
Ed ecco la mossa geniale: non riprendere ma ampliare; anzi, nemmeno ampliare, rilanciare, puntare più un alto, preferendo il rischio verticale al comodo sviluppo orizzontale. In una parola: esplicitare, potenziare, portare all’estremo tutti quegli elementi vincenti cui ho appena accennato (debitore della sapiente recensione delle prime due stagioni a firma M. Mocciola, da rileggere subito qui). La terza stagione non è che questo, e funziona benissimo, colpisce al cuore lo spettatore, incantato dal virtuosismo stilistico, dove ovviamente ha una sua parte (inevitabile, gli hater se ne facciano una ragione) la smaccata auto-referenzialità, l’auto-consapevolezza di una serie divenuta un ‘mito’ di questi anni, capace di creare le sue proprie icone (a partire dalle maschere daliniane). Non importa se gli snob continueranno a giudicarla negativamente (scambiando per grossolano e malfatto ciò che è volutamente scanzonato e tamarro-cool), con questa terza stagione la Casa di Carta si dimostra una serie esteticamente raffinatissima.
Gli esempi di questa dimensione ‘iper’ sono innumerevoli, mi limiterò a una breve panoramica:
– Stavolta il piano è duplice (liberare Rio e rubare l’oro della Banca di Spagna), e perciò più complicato, più difficile, più pericoloso, più soggetto all’alea;
– Il ritmo generale della vicenda è ancora più sincopato e veloce;
– La storia si dipana su (almeno) tre piani temporali differenti, continuamente alternati;
– Il cristianesimo è omaggiato ulteriormente, con l’ambientazione-chiave del bellissimo monastero fiorentino, così come l’idea di resistenza/rivoluzione si carica al massimo, divenendo tema fondamentale;
– Il senso di appartenenza affettiva alla “famiglia criminale” si accentua enormemente, mentre il confronto/scontro simbolico tra i protagonisti si fa ancora più marcato, fino alla polarizzazione giocosamente stereotipatissima maschi/femmine: al culmine di un divertente battibecco, per un attimo uomini etero e gay si alleano su una concezione maschile, leggera e “cinica” del sesso, il “bum bum ciao”, di contro alle ragioni dell’Amore, al femminile sentimentalismo “buono” e “responsabile” caldeggiato da Nairobi e in fondo condiviso anche da Tokio, bad girl bisognosa d’amare;
– Alcuni personaggi già noti assurgono a splendide vette di caratterizzazione nonché di overacting (Berlino diviene in toto un esteta-filosofo del furto; Arturo Roman ossia Arturito si crea una fittizia identità mediatica per occultare la sua miseria umana, in una sorta di parodia di Frank T.J. Mackey, il Tom Cruise di Magnolia, nell’epoca dei TED Talks) e altri, nuovi, sembrano racchiudere in sé questo spirito eccessivo – su tutti, l’ispettrice Alicia Sierra, donna incinta priva di qualsivoglia tenerezza materna, spietata manipolatrice e torturatrice, figura cattivissima dai toni comico-grotteschi (un tipo che piacerebbe di sicuro al già nominato Alex de la Iglesia);
– Infine, il finale, aperto – su una quarta stagione in lavorazione – e insieme punto a capo, in cui i nodi vengono al pettine, rimette tutto in questione, mostrando come il gioco dei rapinatori finisca in tragedia. Giacché la lotta si fa molto più netta e dura, lo scontro con le autorità è conclamato, il popolo manifesta in piazza a favore dei fuorilegge, i quali denunciano gli abusi del mondo del potere (la tortura in prigioni fuori giurisdizione, i torbidi segreti di Stato contenuti nella banca) e, in consonanza con ciò, i metodi della polizia si fanno più brutali, più sleali, e di mossa in mossa si arriva a oltrepassare la linea, si giunge al punto di non ritorno… Al gioco di strategia del Professore, capobanda devoto alla dea dell’intelligenza Atena fino all’ascesi semi-virginale (difatti ha saputo sedurre con l’intelletto Raquel/Lisbona ma poi è goffo e inesperto nella quotidianità dell’amore, anzi quasi lo rifugge), subentra il volto irrazionale e violento di quella che non può che dirsi ormai una vera e propria guerra: è giunto il tempo del dio Ares. Il tempo del clangore, del fuoco e del sangue, della distruzione fragorosa (fidatevi, noi Sorci Verdi ne sappiamo qualcosa, di guerra).
Staremo a vedere. Come le altre volte.
Massimiliano Peroni