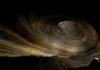Arthur Cravan, nato Fabian Avenarius Lloyd: pugile, poeta, prosatore, pescatore. Arthur Cravan, 1 metro e 98 cm (c’è chi arrotonda per eccesso a 2 metri) spalmati su 100 kg (alcuni giurano 110) di eclettismo. Adelphi propone ora una scelta delle sue opere che spaziano fra articoli, poesie e lettere. “Maintenant”, la rivista di cui era editore, redattore, correttore di bozze, demiurgo, ha goduto delle sue prove di articolista più frizzanti: e gli va certamente riconosciuto un certo camaleontismo letterario, capace com’è stato di passare da un decalogo – al vetriolo – da rispettare per sembrare perfetti americani (almeno un paio di gag disseminate in Snatch da Guy Ritchie sembrano uscite direttamente da queste pagine), alla straniante narrazione di un incontro impossibile avvenuto fra lui e lo zio Oscar Wilde, al tempo ampiamente deceduto – fardello ereditario di cui Cravan andava smaccatamente fiero – avvenuto in una sera di pioggia e melanconia, avanzando poi con la cronaca stizzita di un colloquio insipido ottenuto con lo sfuggente André Gide e chiudendo con note selvatiche, allo stato brado, sulla vita vissuta.
Leggendo d’un fiato, sembra di stare sulle montagne russe: a delle trovate simpatiche e riuscite, (E se per caso un signore più acuto domandasse curioso: “Che lavoro fa quel signore?”, “Il signore è americano” gli sarà puntualmente risposto. E il signore si riterrà sempre soddisfatto della risposta), si alternano sensazioni di pericoloso déjà-vu letterario, con la mente che corre lesta alle squisite stilettate di Oscar Wilde, che emergono proprio dalle pagine di racconto-incontro con lo zio e con Gide; pagine che scorrono veloci, anche troppo. Si torna in alto con la fragorosa “recensione” della mostra d’arte al Salone degli Indipendenti: Cravan qui decide di non fare prigionieri, apre il fuoco a ventaglio, distrugge senza rimorsi tutto quello che gli si para davanti (“Tanto per cominciare, trovo che per un artista la prima condizione sia quella di saper nuotare”, “André Ritter espone una porcheria assoluta. Eccone uno che è osceno e non sa di esserlo. Ermein, un altro cretino”, “Metzinger, un fallito che si è aggrappato al cubismo. Il suo colore ha l’accento tedesco. Mi ripugna” e dulcis in fundo il bersaglio grosso, “L’ebreo Apollinaire…”, e questa non è che una stringata selezione: Cravan sembra davvero averne per tutto il genere umano, pare), e quando gli vengono chieste scuse formali per l’utilizzo di toni ben sopra le righe, carica ulteriormente la trovata con le giustificazioni più sprezzanti e il dileggio più esplicito. È però con le Annotazioni finali che si raggiunge il culmine della sezione prosa: pensieri liberi, totalmente slegati fra loro, come cavalli imbizzarriti che tempestano la carta di zoccolate tali da far tremare gli occhi del lettore. Tutti cavalli di razza, col pelo lucido e i fianchi imponenti: “Io governo i miei occhi come fossero regni – Se si affidasse la direzione dell’universo a Goethe le stelle farebbero ben presto delle stranezze – Languore degli elefanti, romanza dei lottatori – Il vento solleva la polvere dei cesari…”. Tutti cavalli pezzati, tutti cavalli vincenti.
Eclettismo, s’è detto. Ma cosa succede quando Cravan incontra la poesia? Apparentemente, si tratta di laboriosità alchemica: le sensazioni, i sentimenti che vorrebbe instillare nel futuro e possibile lettore, egli li ritrova su di sé, mutati e fuori controllo. Un rivolo di malinconia s’è fatto cascata, i giorni di gioventù passati in fuga sembrano adesso una terribile perdita di tempo – c’è una certa eco del destino romanzesco di quelle vite che diventeranno cartolina – e d’improvviso panciotto, cravattino a farfalla e sparato sembrano inutili, davanti alla pur vaga idea di un dio. La ricerca della rima pizzica, talvolta, quella smania di veemenza con cui Cravan prova a scacciare quel terribile alone di smarrimento che lo avviluppa; e si impegna, si impegna terribilmente per far quadrare i conti, che però non sempre tornano. Si può tradurre così, la graduale mancanza di forza che affligge “Parole”: una candela che si consuma, concedendo sempre meno luce, mentre anche fuori il giorno sfiorisce. L’apogeo è rappresentato da “Arthur”, manifesto languido come le acque di un grande fiume, improvvisamente increspate dal passaggio di un battello, che tornano presto a specchiarsi nel sole: Arthur Cravan non cerca il suo posto nel mondo, Arthur Cravan è il mondo: “Gasteropode amaro… e sorridevo all’erba, / grande trampoliere smarrito / triste di essere un pugile / ho bisogno di soldi / Dio santo, che razza di tempo e di primavera!”. Non c’è alcun tentativo di liberazione, soltanto la presa di coscienza di essere vivo, di avere un destino, qualunque esso sia: e dunque, una proprietà inestimabile. D’altro canto, sono quelle parole che tornano spesso gli indizi che Cravan lascia cadere, condannando noi a costruire la sua biografia – vera o falsa, non importa. Potremmo infatti farne ciò che vogliamo, all’autore la nostra versione interesserebbe meno del nulla cosmico. Così si congedano “Languore di elefante” e “Ih!”: come una sciarada silenziosa alla ricerca di un suono già colto, di un carattere già letto.
La selezione dell’opera di Cravan si conclude con la pubblicazione di alcune sue lettere, in maggioranza all’amata Mina Loy, che sposerà all’inizio del 1918. Ma non manca la chicca di una missiva spedita a Félix Fénéon, in cui il pugile-poeta illustra i suoi studi, condivide con slancio le sue passioni, si mostra entusiasta dell’arrivo di nuovi pugili con cui potrà misurarsi (e vincere?). La conclusione è il vero bonbon dello scritto: “Mi sono ritirato nella mia torre d’acciaio”, confessa candidamente; il tono è alquanto scherzoso, ma non avrebbe potuto essere più profetico: l’anno successivo, dopo una liaison con Sophia Treadwell che ha molto del flirt da cocktail party e poco dell’amore immortale, la sua vita verrà definitivamente sconvolta dalla poetessa Mina Loy. La devastazione ch’ella provoca nell’animo di Cravan è così sconvolgente che ci è possibile toccarla quasi con mano, soltanto sfiorando la carta. Un dolore fisico, spirituale, totale accompagna le suppliche di risposta che l’autore spedisce con forsennata frequenza, mentre sbanda pericolosamente verso la follia amorosa. Al colmo della disperazione, promette con parole di sangue ciò che, in realtà, mai potrebbe mantenere: cambiare se stesso, dominarsi e convertirsi alla tranquillità. Un animo così tumultuoso, così abituato a stare nel mezzo della baruffa – non si vergogna di ribadire che scrive “to enrage my colleagues, to get talked about and to try and make a name for myself” – non potrà mai placarsi: non per raggiungere la pace egli è venuto al mondo. Ed è un gran pugno nello stomaco, per il lettore, fare i conti con questo Cravan quotidiano, che si vuol costringere ad avere un contegno clericale, mentre si sovrappone al rissaiolo verbale in giacca e cravatta impegnato in una crociata a favore della libertà d’essere immorali. Stupisce e commuove la tenerezza di un gigante innamorato, conscio che migliaia di km lo separano dalla creatura amata. Pugni e carezze: di tutto fu capace questo dandy coi guantoni. È possibile – se non probabile – che il ricongiungimento con l’amata l’abbia davvero salvato dalla pazzia (i toni lugubri dell’abbandono di se stesso sono chiaramente percepibili: “Ho pianto a tal punto che ho pensato di mandarti una boccetta di lacrime che potresti far analizzare per accertarti che non contenga altro che lacrime”, iperbole ancora più pericolosa in quanto scritta da un esageratore seriale); si provi ad immaginare la forza, guidata dalla disperazione, necessaria a scrivere una chiosa di questo genere: “Morire nell’anima è mille volte peggio del cancro. E io sono più spacciato. Se sapessi come mi sento puro. Ho già messo le ali e tutto ciò andrà perduto”, da una lettera datata 31 dicembre 1917. Meno di un mese dopo, egli poteva riabbracciare l’amata a Città del Messico. Nella spasmodica attesa di quell’abbraccio, sarebbe stato curioso chiedere a Cravan cosa avesse preferito: battere Jack Johnson alla quarta ripresa, con un montante preparato nei sogni, o ricongiungersi con le labbra di Mina Loy, che i sogni li aveva rovesciati fino a qual momento?
Ad impreziosire il volume, in chiusura, una biografia di Fabian Avenarius Lloyd scritta da Edgardo Franzosini – bastano queste 40 pagine per consigliare l’acquisto del volume, senza dubbio alcuno. Come sempre, come meglio non si potrebbe, è magia: la sua capacità di andare a scovare piccoli eventi, storielle controverse, confessioni barocche, oltre ogni più libera immaginazione, si spinge oltre l’epica. La costruzione della vita di Arthur Cravan poggia proprio su queste piccole chicche; lo sorprendiamo agile ballerino, mentre diviene beniamino della pista, o lo vediamo confessare tutta la propria ammirazione a Jack Johnson – un colosso di colore in completo di lino bianco, ci avverte Franzosini, quasi ci fosse un regista nascosto dietro la penna con la sceneggiatura di un film bell’e pronta – prima di ammettere che dovrà mandarlo al tappeto. Così, rinnovando il gioco di prestigio, Franzosini ci fa perdere pian piano l’interesse per le date, per gli eventi utili ad ancorarsi alla realtà: ci ottunde con gli aromi fumosi del più bel “si dice”, relegando gli avvenimenti oggettivi dietro le quinte, a prender polvere. La coloritura delle note a margine, tentacolari protesi del testo, è ciò che di più spassoso possa capitarvi di leggere. Insomma, ce la racconta più grossa di quel che è, Franzosini (il quale, per me, è come il pifferaio magico: leggendolo, sono in suo potere, ammaliato), as usual: ma in fondo è proprio quello che vogliamo; una favola della buonanotte, disperata e vertiginosa, per sognare di vivere una vita così, passata a scrivere poesie indossando guantoni da 5 libbre.
Glory is a scandal
Mattia Orizio