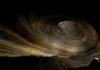Il western è forse il genere più smontato e rimontato del XX secolo; uno pensa che abbia già detto tutto, che l’armamentario di pistoleri, orizzonti sterminati, Peckinpah, saloon, pellerossa, Balla coi lupi, Geronimo, allevatori di bestiame, cercatori d’oro, vendette, diligenze, cavalli, Leone, Ford, revisionismi e parodie, sia stato spremuto a dovere. E invece, puntualmente, si torna alla frontiera. Anche i Coen ci tornano, tornano sul luogo del delitto (Il Grinta) e in una antologica molto stravagante, a modo loro iniziano e concludono un discorso sul genere che risulta originalissimo.
C’è un dato di fatto: il selvaggio West tira ancora, non solo all’estero – basti vedere l’Einaudi come si sta affrettando a pubblicare i romanzi di Larry McMurtry, o pensiamo alle edizioni Sur qualche anno fa con Warlock di Oakley Hall. Insisto sul legame con il genere letterario perché i Coen attingono soprattutto dal discorso scritto prima ancora che da quello visivo: motivo per cui ogni segmento narrativo è introdotto e terminato da una mano che sfoglia un libro di racconti dall’emblematico titolo La ballata di Buster Scruggs e altri racconti della frontiera americana. Racconti che sono paradigmatici, storielle paraboliche di una semplicità disarmante che i Coen hanno scritto nell’arco di 25 anni.
Sul versante cinematografico, invece, il western non si è mai schiodato dalle sale: Tarantino ha già dato con Django Unchained e The hateful eight.
Le serie tv? Deadwood su tutte: non è di molti anni fa, e ancora ci sono fan che chiedono un film per concludere degnamente il finale tronco.
Vogliamo concentrarci sui videogame? Sono mesi che Red Dead Redemption 2 imperversa in ogni dove, al punto tale da essere considerato il più grande videogioco mai fatto. Dopo aver visto la prima mezz’ora del film dei Coen ammetto: a tratti ne La ballata sembra di vedere parti che starebbero alla perfezione in entrambi i capitoli del videogame Rockstar, quasi come fossero missioni secondarie o principali di un mondo sterminato.
Sul versante cinematografico, invece, il western non si è mai schiodato dalle sale: Tarantino ha già dato con Django Unchained e The hateful eight.
Le serie tv? Deadwood su tutte: non è di molti anni fa, e ancora ci sono fan che chiedono un film per concludere degnamente il finale tronco.
Vogliamo concentrarci sui videogame? Sono mesi che Red Dead Redemption 2 imperversa in ogni dove, al punto tale da essere considerato il più grande videogioco mai fatto. Dopo aver visto la prima mezz’ora del film dei Coen ammetto: a tratti ne La ballata sembra di vedere parti che starebbero alla perfezione in entrambi i capitoli del videogame Rockstar, quasi come fossero missioni secondarie o principali di un mondo sterminato.
La ballata di Buster Scruggs è difficile da definire, a partire dal primo episodio (su sei, dalla durata variabile) che compone l’antologia: venti minuti scarsi dove i Coen calcano di brutto la mano, tirando fuori una vicenda a metà tra il cartone animato e la parodia da musical con un protagonista (il Buster Scruggs del titolo, ispirato sembra a Lucky Luke) invincibile all’apparenza. La sua vicenda (ultra)terrena è condita da una violenza esagerata, spiazzante.
Il secondo segmento narrativo (“Near Algodones”) non si discosta poi tanto dalla falsariga de “La ballata”: nella prima sequenza sembra omaggiare il Leone del dollaro, per poi diventare subito dopo scopertamente coeniano (il vecchio con le padelle, la sfiga clamorosa di James Franco, la battuta sulla forca “è la tua prima volta?”).
Ma è dal terzo minifilm (“Meal Ticket”) che le cose iniziano a diventare non solo meno comiche, ma anche molto desolate, a loro modo persino poetiche: tanto che sembra di vedere un mix tra una fiaba Disney e La strada di Fellini trasportata di peso nell’ambiente duro, selvaggio e silenzioso del western meno esibito al cinema. È la storia del rapporto tra un impresario e un mutilato che recita per lui. Episodio ripetitivo nei monologhi del ragazzo, scarno di dialoghi, spietato senza mostrare nessuna scena di violenza.
Il quarto (“All gold canyon”), con un Tom Waits in stato di grazia, è l’ennesimo esempio di imprevedibilità: la storia del classico vecchio cercatore d’oro e del rapporto tra civiltà e natura (uno dei temi fondamentali del genere), con un inizio che sembra uscito da Chaplin e una brusca sterzata nella violenza sul finale.
Lo spettatore più scafato avrà già capito da qui l’obiettivo dei Coen: in pratica, ogni episodio sarà una declinazione dei topoi del genere, oltre ad essere il ribaltamento di queste stesse regole, che però non tradiscono lo spirito della tradizione.
Stile visivo e scrittura dei Coen si adattano alla perfezione al genere western, come se non avessero mai fatto altro. Infatti non è solo il West, ma tutto il cinema coeniano ad essere una lotta per la sopravvivenza spietata: è un cinema dove, da sempre, chi prova a seguire una determinata traiettoria e dominare la situazione senza conoscere le regole del gioco può finire male da un momento all’altro; basta una piccola deviazione del destino, una leggera debolezza, e il caso darà le carte sbagliate. Se chi riceve le carte non sa quando e come barare per lui è finita. In tal senso, il quinto episodio (“The gal who got rattled”) con la giovane ragazza e la carovana è il più emblematico di tutti, persino il più romantico, e forse il più bello anche: la difficoltà per una donna di adattarsi a un ambiente ostile, l’illusione di avere possibilità di scelta, la goffaggine del corteggiamento, il finale sospeso in modo sublime… Non a caso è l’episodio più lungo del lotto: i Coen devono essersene innamorati perché (azzardo) deve essere questa la loro idea pura di western, che sembra tornare nuovamente dalle parti de Il Grinta.
La sesta e ultima storia (“The mortal remains”) è una rievocazione parziale di Ombre rosse, il più classico dei classici dei western: con tanto di diligenza, personaggi che si buttano in dialoghi ironici da scompisciarsi, e un finale con imprevista (ancora!) deviazione nel gotico – ma stiamo ancora a John Ford, o è Mario Bava? Quante contaminazioni sono possibili per il genere più codificato di sempre e più “cosmopolita” (il cinema di samurai e il cinema di pistoleri hanno avuto una vita simbiotica molto strana), più rigido all’apparenza, eppure, come dimostrano i Coen, anche più malleabile?
Il secondo segmento narrativo (“Near Algodones”) non si discosta poi tanto dalla falsariga de “La ballata”: nella prima sequenza sembra omaggiare il Leone del dollaro, per poi diventare subito dopo scopertamente coeniano (il vecchio con le padelle, la sfiga clamorosa di James Franco, la battuta sulla forca “è la tua prima volta?”).
Ma è dal terzo minifilm (“Meal Ticket”) che le cose iniziano a diventare non solo meno comiche, ma anche molto desolate, a loro modo persino poetiche: tanto che sembra di vedere un mix tra una fiaba Disney e La strada di Fellini trasportata di peso nell’ambiente duro, selvaggio e silenzioso del western meno esibito al cinema. È la storia del rapporto tra un impresario e un mutilato che recita per lui. Episodio ripetitivo nei monologhi del ragazzo, scarno di dialoghi, spietato senza mostrare nessuna scena di violenza.
Il quarto (“All gold canyon”), con un Tom Waits in stato di grazia, è l’ennesimo esempio di imprevedibilità: la storia del classico vecchio cercatore d’oro e del rapporto tra civiltà e natura (uno dei temi fondamentali del genere), con un inizio che sembra uscito da Chaplin e una brusca sterzata nella violenza sul finale.
Lo spettatore più scafato avrà già capito da qui l’obiettivo dei Coen: in pratica, ogni episodio sarà una declinazione dei topoi del genere, oltre ad essere il ribaltamento di queste stesse regole, che però non tradiscono lo spirito della tradizione.
Stile visivo e scrittura dei Coen si adattano alla perfezione al genere western, come se non avessero mai fatto altro. Infatti non è solo il West, ma tutto il cinema coeniano ad essere una lotta per la sopravvivenza spietata: è un cinema dove, da sempre, chi prova a seguire una determinata traiettoria e dominare la situazione senza conoscere le regole del gioco può finire male da un momento all’altro; basta una piccola deviazione del destino, una leggera debolezza, e il caso darà le carte sbagliate. Se chi riceve le carte non sa quando e come barare per lui è finita. In tal senso, il quinto episodio (“The gal who got rattled”) con la giovane ragazza e la carovana è il più emblematico di tutti, persino il più romantico, e forse il più bello anche: la difficoltà per una donna di adattarsi a un ambiente ostile, l’illusione di avere possibilità di scelta, la goffaggine del corteggiamento, il finale sospeso in modo sublime… Non a caso è l’episodio più lungo del lotto: i Coen devono essersene innamorati perché (azzardo) deve essere questa la loro idea pura di western, che sembra tornare nuovamente dalle parti de Il Grinta.
La sesta e ultima storia (“The mortal remains”) è una rievocazione parziale di Ombre rosse, il più classico dei classici dei western: con tanto di diligenza, personaggi che si buttano in dialoghi ironici da scompisciarsi, e un finale con imprevista (ancora!) deviazione nel gotico – ma stiamo ancora a John Ford, o è Mario Bava? Quante contaminazioni sono possibili per il genere più codificato di sempre e più “cosmopolita” (il cinema di samurai e il cinema di pistoleri hanno avuto una vita simbiotica molto strana), più rigido all’apparenza, eppure, come dimostrano i Coen, anche più malleabile?
Nicola Laurenza